Descrizione
1
Ricordo esattamente dov’ero e cosa stavo facendo quando vidi mio padre morire. Mi trovavo più o meno dov’ero adesso, affacciata alla veranda di legno che circondava casa nostra, a guardare i raccoglitori farsi strada lungo i filari ben curati, gravidi di grappoli per la vendemmia di quell’anno. Stavo giusto per scendere i gradini e raggiungerli, quando con la coda dell’occhio vidi quell’omone che era mio padre sparire di colpo. Subito pensai che si fosse inginocchiato per prendere un grappolo d’uva caduto – detestava gli sprechi di ogni genere, concetto che attribuiva alla mentalità presbiteriana dei suoi genitori scozzesi –, ma poi vidi i raccoglitori precipitarsi verso di lui dai filari vicini. Si trovava a un buon centinaio di metri dalla veranda, e quando lo raggiunsi, trafelata, qualcuno gli aveva strappato la camicia e stava cercando di rianimarlo con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, mentre un altro aveva chiamato il numero di emergenza. L’ambulanza arrivò solo venti minuti dopo.
Già quando lo sollevarono sulla barella, capii dal volto ormai cereo che non avrei mai più sentito la sua voce potente, tanto carica di solennità, ma che in un attimo sapeva trasformarsi in una risatina gutturale. Con le lacrime che mi rigavano il viso, l’avevo baciato delicatamente sulla guancia rossastra e segnata dalle intemperie, gli avevo detto che gli volevo bene e dato l’addio. Ripensandoci, quell’esperienza tremenda era stata surreale: il suo passaggio dall’essere così pieno di vita a, be’… nient’altro che un corpo vuoto, esanime, era impossibile da accettare.
Dopo mesi di dolori al petto, che fingeva fossero dovuti alla cattiva digestione, papà si era finalmente convinto a vedere un medico. Risultò che aveva il colesterolo alto, e avrebbe dovuto seguire una dieta. Io e mia madre avevamo perso le speranze, vedendolo continuare a mangiare quello che voleva e bere una bottiglia del suo vino rosso ogni sera. Perciò non avremmo dovuto stupirci, se mai fosse arrivato il peggio. Forse lo credevamo indistruttibile, e del resto il suo carattere forte ma bonario contribuiva all’illusione, ma, come aveva cupamente sottolineato mia madre una volta, alla fine non siamo che carne e ossa. Almeno aveva vissuto come voleva fino all’ultimo. Aveva anche compiuto settantatré anni, dato di cui semplicemente non riuscivo a tenere conto, viste la sua prestanza fisica e la gioia di vivere che sprigionava.
Di conseguenza mi sentii ingannata. Dopotutto avevo solo ventidue anni e, anche se avevo sempre saputo che i miei genitori mi avevano avuta tardi, colsi il senso di questa circostanza soltanto alla morte di papà. Nei pochi mesi trascorsi da quando era mancato, avevo provato rabbia per quell’ingiustizia: perché non ero entrata prima nella loro vita? Mio fratello Jack, che di anni ne aveva trentadue, se ne era goduti ben dieci in più insieme a papà.
Mamma ovviamente percepiva la mia rabbia, anche se non le avevo mai detto nulla apertamente. E poi mi sentivo ingiusta, perché non era in alcun modo colpa sua. Le volevo un bene dell’anima; eravamo sempre state molto legate, e vedevo quanto anche lei fosse addolorata. Facevamo del nostro meglio per confortarci a vicenda, e in qualche modo ne uscimmo insieme. Anche Jack era stato meraviglioso, dedicandosi quasi a tempo pieno a sistemare le odiose incombenze burocratiche successive al decesso. Si era anche fatto carico da solo di The Vinery, l’azienda fondata da mamma e papà, che almeno per questo compito l’aveva già preparato a dovere.
Fin da bambino, infatti, lo portava con sé ad assistere al ciclo annuale di coltivazione dei suoi preziosi vigneti che, tra febbraio e aprile, a seconda del tempo, avrebbero prodotto i grappoli destinati alla vendemmia, per poi culminare nelle deliziose – e recentemente premiate – bottiglie di pinot nero che giacevano nel magazzino, pronte per essere esportate in tutta la Nuova Zelanda e in Australia. Illustrava con cura al figlio le diverse fasi del processo, e all’età di dodici anni Jack sarebbe stato probabilmente già in grado di dirigere il personale, tante erano le nozioni impartitegli da papà. A sedici anni Jack aveva ufficialmente annunciato di voler lavorare con lui e, un giorno, rilevare The Vinery, con enorme gioia di papà.
Si era laureato in economia, dopodiché aveva cominciato a lavorare a tempo pieno al vigneto.
«Non c’è niente di meglio che trasmettere una florida eredità» aveva detto papà qualche anno prima brindando in suo onore, al ritorno dal tirocinio di sei mesi svolto da Jack presso un’azienda vinicola nelle Adelaide Hills, in Australia. Ormai lo riteneva pronto.
«Forse un giorno sarai dei nostri anche tu, Mary-Kate. Brindiamo ai McDougal, che possano produrre vino su questa terra ancora per secoli e secoli!»
Se Jack aveva scommesso sul sogno di papà, non era stato lo stesso per me. Forse perché mio fratello era sinceramente affascinato dalla produzione dei vini pregiati: oltre a saper riconoscere a naso una vite selvatica a chilometri di distanza, era anche un ottimo uomo d’affari. Dal canto mio, ero cresciuta guardando papà e Jack perlustrare le vigne e sgobbare in quello che chiamavano affettuosamente The Lab (nient’altro che un grande capanno col tetto di lamiera, in realtà). Erano altre, però, le cose che avevano catturato il mio interesse. Ormai consideravo The Vinery un’entità separata da me e dal mio futuro. Questo non mi aveva impedito di lavorare nel nostro negozietto durante le vacanze scolastiche e universitarie, o di aiutare quando c’era bisogno, ma il vino non era decisamente la mia passione. Nonostante la percepibile delusione di papà al mio annuncio di voler studiare musica, aveva avuto la delicatezza di capire.
«Buon per te» aveva detto abbracciandomi. «La musica è un mondo molto vasto, Mary-Kate. In quale campo ti vedi in futuro?»
Timidamente, gli risposi che un giorno avrei voluto diventare una cantante e scrivere le mie canzoni.
«Ma è un sogno favoloso, non posso che augurarti buona fortuna e dirti che io e tua madre saremo sempre al tuo fianco.»
«Mi pare stupendo, Mary-Kate, davvero» aveva detto mamma. «Esprimere se stessi con una canzone è qualcosa di magico.»
E dunque avevo studiato musica, scegliendo l’università di Wellington che offriva un percorso di prim’ordine, e mi piaceva un sacco. Poter contare su uno studio all’avanguardia in cui registrare le mie canzoni, e avere intorno compagni che vivevano per la mia stessa passione, era straordinario. Avevo formato un duo tastiera e chitarra ritmica col mio grande amico Fletch, la cui voce si armonizzava bene con la mia. Eravamo riusciti a fare qualche serata a Wellington, esibendoci anche al saggio dell’ultimo anno: era stata la prima volta in cui la mia famiglia mi aveva visto cantare e suonare dal vivo.
«Sono davvero fiero di te, MK» aveva detto papà, stringendomi in un forte abbraccio.
Era stato uno dei momenti più belli della mia vita. «E ora eccomi qui, un anno dopo, con una laurea inutile in tasca e di nuovo in mezzo alle viti» mormorai. «Sii sincera, MK, pensavi davvero che venisse la Sony a pregarti di firmare un contratto?»
Da quando avevo terminato gli studi, l’anno prima, mi ero via via sempre più scoraggiata riguardo alle prospettive future, e la morte di papà aveva dato un colpo durissimo alla mia creatività. Mi sembrava di aver perso nello stesso momento due dei più grandi amori della mia vita, soprattutto perché erano inscindibilmente legati fra loro. Erano state le cantautrici tanto amate da papà ad aver acceso per prime la mia passione per la musica. Ero cresciuta ascoltando Joni Mitchell, Joan Baez e Alanis Morissette.
Gli anni a Wellington mi avevano anche fatto capire quanto protetta e idilliaca fosse stata la mia infanzia, trascorsa in quell’autentico Giardino dell’Eden che era la Gibbston Valley: le montagne attorno a noi formavano una barriera fisica rassicurante e la terra fertile, come per magia, dava frutta succulenta in abbondanza.
Ricordo Jack, adolescente, che cercava di farmi mangiare con l’inganno l’uva spina selvatica dei rovi dietro casa nostra, e la sua risata mentre la sputavo disgustata. All’epoca me ne andavo liberamente a zonzo, i miei genitori non ci badavano: mi sapevano perfettamente al sicuro nella splendida campagna circostante, a giocare nei ruscelli freschi e limpidi e a inseguire i conigli nell’erba alta. Mentre loro faticavano nel vigneto, occupandosi di tutto, dal piantare le viti al proteggerle dai voraci animali selvatici, fino alla vendemmia e alla pigiatura, io vivevo nel mio mondo incantato.
Il radioso sole del mattino fu all’improvviso oscurato da una nube, che tinse la valle di un cupo color grigioverde. Era un segno dell’arrivo dell’inverno e, non per la prima volta, mi chiesi se avessi fatto bene a scegliere di passarlo lì. Qualche mese addietro mamma aveva accennato all’idea di partire in quello che definì un “Grand Tour” del mondo, per fare visita ad amici che non vedeva da anni. Mi aveva chiesto se avessi voluto andare con lei. Al tempo speravo ancora che il demo registrato con Fletch, che avevamo spedito alle case discografiche di mezzo mondo prima della morte di papà, potesse suscitare qualche interesse. E invece le lettere dei produttori che etichettavano le nostre canzoni come “non è quello che stiamo cercando al momento” si ammucchiavano su uno scaffale in camera mia.
«Tesoro, non devo dirti io che il music business è uno dei più difficili in cui sfondare» mi aveva ricordato mamma.
«Per questo penso che dovrei restare qui» avevo risposto. «Io e Fletch stiamo lavorando su roba nuova. Non posso abbandonare la nave proprio adesso.»
«No, certo che no. Comunque, se le cose non vanno per il verso giusto, potrai sempre contare su The Vinery» aveva aggiunto lei.
Sapevo che stava solo cercando di essere gentile e avrei dovuto essere grata di poter guadagnare qualcosa lavorando in negozio e dando una mano con la contabilità. Ma ora alla vista del mio Giardino dell’Eden emisi un profondo sospiro: l’idea di passare qui il resto della vita non era quella giusta, per quanto bello e sicuro potesse essere. Tutto era cambiato dai tempi dell’università, e ancora di più dalla morte di papà. Era come se, con la sua scomparsa, il cuore di questo luogo avesse smesso di battere. E la decisione di Jack – che prima della morte di papà aveva accettato di passare l’estate presso un’azienda vinicola francese, nella Valle del Rodano, e in accordo con mamma aveva scelto di partire comunque – non aiutava.
«Il futuro dell’azienda ora è nelle mani di Jack e deve imparare il più possibile» mi aveva detto lei. «Ci penserà Doug a gestire il vigneto; peraltro adesso siamo fuori stagione, è il momento perfetto per andare.»
Ma dal giorno prima, quando mamma era partita per il “Grand Tour”, sommando la sua assenza a quella di Jack, mi sentivo sempre più sola e a rischio di sprofondare ulteriormente nella depressione.
«Mi manchi, papà» mormorai rientrando per fare colazione, pur non avendo fame. Il silenzio di casa non contribuiva certo a tirarmi su il morale; per tutta la mia infanzia aveva pullulato di gente – se non erano fornitori o operai del vigneto, erano visitatori con i quali papà si intratteneva a chiacchierare. Oltre a offrire loro un assaggio dei suoi vini, li invitava spesso a fermarsi a cena. L’ospitalità e il calore facevano semplicemente parte della tradizione kiwi, e io ero abituata a sedere accanto a perfetti sconosciuti alla grande tavola di pino che dava sulla vallata. Non avevo idea di come mia madre riuscisse a preparare senza preavviso teglie e teglie di squisiti manicaretti, eppure lo faceva e, con la simpatia di papà, il divertimento e le risate erano assicurati.
Mi mancava anche Jack, quell’energia calma e positiva che emanava sempre. Gli piaceva prendersi gioco di me, ma allo stesso tempo sapevo che potevo contare su di lui, che sarebbe stato sempre al mio fianco.
Presi il succo d’arancia dal frigo e versai ciò che ne restava in un bicchiere, poi sudai sette camicie per tagliare a fette una pagnotta del giorno prima. La tostai per renderla commestibile, poi buttai giù una rapida lista della spesa per rimpinguare le scorte del frigo. Il supermercato più vicino era ad Arrowtown, e sarei dovuta partire a breve. Anche se mamma aveva lasciato nel freezer un bel po’ di spezzatino, non mi sembrava giusto scongelare quei tupperware giganteschi soltanto per me.
Rabbrividendo mi spostai in salotto e mi sedetti sul vecchio divano di fronte all’enorme camino in pietra vulcanica grigia, materiale di cui la zona abbondava. Era stato questo, trent’anni prima, a convincere i miei genitori a comprare quello che un tempo era stato un casotto di una sola stanza, sperduto in mezzo al nulla. Era senza acqua corrente e servizi igienici, ed entrambi amavano ricordare come quella prima estate, insieme al figlio di due anni, si facessero il bagno nel ruscello che scendeva tra le rocce vicine e avessero scavato una vera e propria buca nel terreno a mo’ di toilette.
«Quella fu l’estate più felice della mia vita» diceva mamma «e d’inverno era ancora meglio, grazie al camino.»
Era fissata col fuoco e, non appena nella valle comparivano le prime gelate, io, papà e Jack venivamo spediti alla legnaia a prendere i ciocchi da ardere, ben stagionati nei mesi successivi al taglio. Li accatastavamo nelle nicchie ai lati del caminetto, poi mamma li posava sugli alari e, acceso un fiammifero, dava inizio al rituale di quello che in famiglia chiamavamo il “Primo Fuoco”. Da lì in poi, il camino ardeva allegramente per tutti i mesi invernali, finché le campanule e i bucaneve (di cui si era fatta spedire i bulbi dall’Europa) non spuntavano sotto gli alberi, tra settembre e novembre: era la nostra primavera.
Forse dovrei accenderlo, mi dissi, pensando al caldo, gradevole bagliore che mi accoglieva nei giorni più gelidi della mia infanzia, al rientro da scuola. Se papà era stato metaforicamente il cuore dell’azienda vinicola, mamma e il suo camino erano il cuore della casa.
Poi mi frenai, dicendomi che ero ancora troppo giovane per cercare conforto nei ricordi. Avevo solo bisogno di compagnia, tutto qui. Il problema era che la maggior parte dei miei amici dell’università si trovava all’estero, a godersi gli ultimi giorni di libertà prima di mettere la testa a posto e trovarsi un lavoro, se non lavorava già.
Anche se avevamo una linea fissa, la connessione Internet nella valle funzionava a singhiozzo. Mandare mail era un incubo, e papà era spesso costretto a farsi mezz’ora di strada fino a Queenstown per usare il computer di un amico agente di viaggi. Aveva soprannominato la nostra valle Brigadoon, dal nome di un vecchio film su un villaggio che si risveglia per un giorno ogni secolo, rimanendo immune ai cambiamenti del mondo esterno. Be’, la valle sarà anche stata come Brigadoon – di sicuro negli anni restava più o meno immutata –, ma non era certo il posto dove una cantautrice in erba potesse lasciare il segno. I miei sogni erano tutti ambientati a Manhattan, Londra o Sydney, coi loro edifici torreggianti popolati da produttori discografici che avrebbero reso me e Fletch delle star…
Il telefono irruppe nei miei pensieri, e mi alzai per rispondere giusto in tempo.
«The Vinery, buongiorno» ripetei a pappagallo, come avevo imparato sin da piccola.
«Ciao MK, sono Fletch» mi salutò usando il soprannome con cui mi chiamavano tutti, tranne mia madre.
«Ehi, ciao» dissi, col battito del cuore che accelerava. «Ci sono novità?»
«No, niente, pensavo solo che potrei accettare la tua proposta di stare un po’ da te. Ho un paio di giorni di ferie dal bar e ho bisogno di allontanarmi dalla città.»
E io invece ho bisogno di andarci…
«Oh, fantastico! Vieni pure quando vuoi. Io sono qui.»
«Che ne dici di domani? Vengo in macchina, mi prenderà quasi tutta la mattinata; sempre che Sissy ce la faccia, ovviamente.»
Sissy era il nostro furgone per i concerti. Aveva vent’anni, ruggine ovunque e perdeva dal tubo di scappamento traballante, che Fletch aveva temporaneamente riparato con una corda. C’era da sperare che potesse reggere le tre ore di viaggio da Dunedin, dove Fletch viveva con la sua famiglia.
«Quindi ci vediamo per pranzo?» domandai.
«Sì, non vedo l’ora. Sai quanto mi piaccia lì da te. Magari possiamo metterci anche un’oretta o due al piano, a comporre qualcosa di nuovo…»
«Magari» risposi, sapendo che non stavo attraversando un momento particolarmente creativo. «Ciao Fletch, a domani.»
Chiusi la chiamata e tornai sul divano, sentendomi adesso più serena per il suo arrivo: riusciva sempre a tirarmi su, col suo senso dell’umorismo e l’ottimismo contagioso.
Dall’esterno giunse un grido, seguito da un fischio: era il segnale con cui Doug, il nostro responsabile del vigneto, ci avvertiva della sua presenza. Mi alzai, andai alla terrazza e lo vidi addentrarsi tra le vigne spoglie, in compagnia di un gruppo di massicci isolani del Pacifico.
«Ehilà!» urlai in risposta.
«Ciao, MK! Faccio vedere ai ragazzi da dove cominciare con la potatura» replicò Doug.
«Benissimo. Ciao ragazzi!» gridai all’indirizzo della sua squadra, che rispose con un cenno al mio saluto.
La loro presenza aveva rotto il silenzio, e proprio in quel momento il sole riapparve da dietro una nuvola; la vista di altri esseri umani, unita alla prospettiva dell’arrivo di Fletch il giorno dopo, riuscì a sollevarmi il morale.



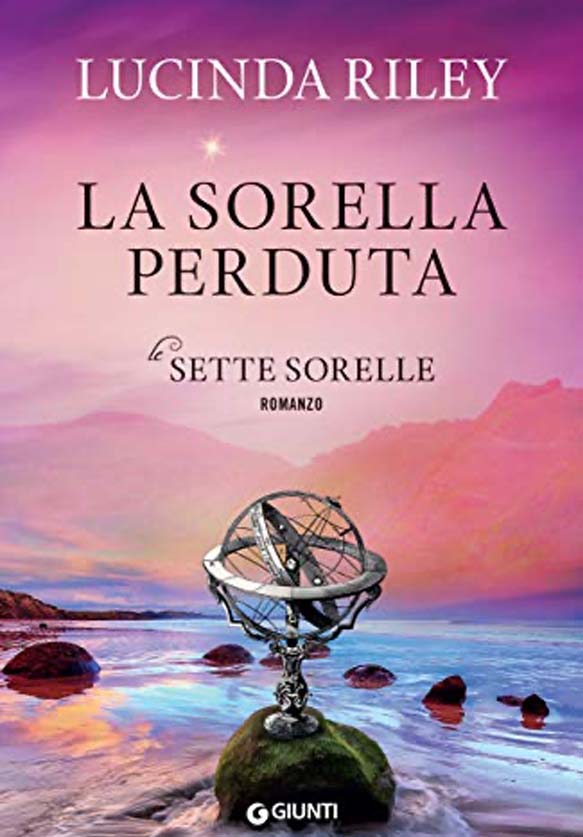


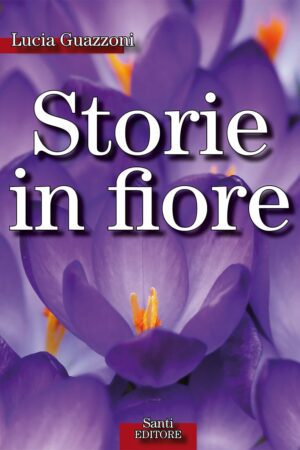




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.